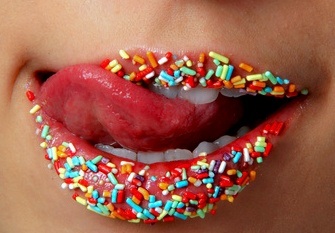
Amaro
La sensazione amara è evocata da una varietà di composti tra cui cationi bivalenti (Mg2+), alcuni amminoacidi, alcaloidi (chinino, stricnina, nicotina, caffeina) e il denatonio, la sostanza più amara conosciuta. Poiché molti alcaloidi sono tossici, l’evoluzione di questa modalità gustativa potrebbe avere un ruolo difensivo. Coerentemente questa modalità gustativa è, in tutti i mammiferi, quella con la soglia più bassa. Infatti, il chinino dà la sensazione di amaro già ad una concentrazione di 10-5 M. Le sostanze in grado di evocare una sensazione gustativa amara appartengono ad un gruppo molto eterogeneo che comprende composti sia idrosolubili sia liposolubili. Ciò sembrerebbe suggerire la presenza di più di un meccanismo di trasduzione.
Nel sistema gustativo è stata identificata una specifica proteina G, simile alla transducina24 del sistema visivo, che è stata denominata gustducina25. Topi mutanti che sono privi della subunità α della gustducina (α-gustducina) non rispondono a stimoli amari (ed anche dolci). E’ stato proposto che la α-gustducina attivi una fosfodiesterasi gustativa (PDE) la quale abbasserebbe i livelli intracellulari di nucleotidi ciclici modulando conseguentemente delle conduttanze ioniche apicali. Sono probabilmente presenti anche dei meccanismi diversi. Alcune sostanze amare (6-n- propil-tiouracile, denatonio) innalzano i livelli di IP3, determinando rilascio di calcio dai depositi intracellulari. La subunità γG13 delle proteine G colocalizza con la gustducina ed attiva una fosfolipasi (PLCβ2) specifica del sistema gustativo. Si è conseguentemente pensato alla presenza di un eterotrimero α-gustducina/β3/γ13 in cui la subunità α attiverebbe la PDE mentre il complesso βγ attiverebbe la fosfolipasi.
Inoltre la chinina ed i cationi bivalenti sono in grado di bloccare direttamente dei canali potassio situati sul polo apicale delle cellule, determinando conseguentemente una depolarizzazione cellulare. In effetti molti bloccanti dei canali potassio possono avere un gusto amaro.
3.1.2 Dolce
La struttura chimica dei composti riconosciuti come dolci è molto varia. Si tratta in genere di sostanze organiche quali polialcoli (tra cui gli zuccheri) ma anche aldeidi, chetoni e sostanze aromatiche (ad es. la saccarina). La percezione del gusto dolce sembra mediata dal legame del sapore con uno specifico recettore di membrana. La trasduzione può avvenire con due differenti meccanismi. Nei roditori l’interazione del gusto dolce, ad esempio saccarosio, con il recettore induce un aumento dalla concentrazione intracellulare di cAMP, con conseguente attivazione di una kinasi c- AMP dipendente (PKA) che fosforila, inattivandoli, dei canali potassio della porzione basolaterale della cellula. Poiché essi sono normalmente aperti al potenziale di riposo della cellula, la loro chiusura determina depolarizzazione. Sempre nei roditori, alcuni dolcificanti artificiali inducono, attraverso l’attivazione di un’altra G-protein, un incremento dell’IP3 all’interno della cellula. Questo aumento può a sua volta indurre il rilascio di calcio dai siti di
deposito intracellulari. Si è anche osservato che, in un ceppo mutante di topo nel quale è assente la α-gustducina (Vedi § 3.1.1.), vi sono dei deficit nella risposta ad alcune sostanze dolci.
L’effettivo contributo delle produzione e degradazione del cAMP e del turnover dell’IP3 nella traduzione del gusto dolce sono ancora oggetto di indagine.
3.1.3 Salato
Gli stimoli salati (ad esempio NaCl) sono tradotti almeno in parte dalla diffusione, sostenuta dal gradiente elettrochimico, di ioni Na+ attraverso canali apicali sensibili all’amiloride26. Questo influsso di sodio è di per sé depolarizzante. In effetti, l’amiloride interferisce con la capacità di riconoscere il salato nell’uomo. Un simile meccanismo può essere evocato nel caso degli ioni K+. Le differenze quantitative nella risposta evocata da diversi sali sodici possono essere dovute alla diversa abilità dell’anione di superare le tight junctions tra le cellule gustative e di interessare quindi il lato basolaterale della membrana.
3.1.4 Acido
Il gusto acido è evocato dalla dissociazione acida della sostanze sapide. Negli anfibi la percezione del gusto acido sembrerebbe dovuto al blocco di canali potassio apicali da parte degli ioni H+, con conseguente depolarizzazione. Nel criceto vi sarebbe invece un influsso di H+ attraverso i canali sensibili all’amiloride che diventano permeabili ai protoni quando la concentrazione di sodio nella saliva è bassa. Quando invece è alta, i protoni bloccano l’influsso di sodio inibendo la risposta al NaCl. Coerentemente, nell’uomo le sostanze acide riducono la risposta al salato. Infine gli ioni H+ potrebbero modulare l’apertura di canali ionici permeabili ai cationi.
3.1.5 Umami
Il glutammato e l’aspartato molto probabilmente interagiscono con una categoria di recettori gustativi a sé stanti. Si tratterebbe di recettore metabotropo per il glutammato (mGluR4) che viene espresso anche in alcune regioni del SNC. La forma specifica presente a livello delle cellule gustative è una ridotta di circa 300 amminoacidi, all’estremità amminica (extracellulare). Questa modalità gustativa viene evocata anche da 5’ribonucleotidi e dal guanilato bisodico.
La sensazione amara è evocata da una varietà di composti tra cui cationi bivalenti (Mg2+), alcuni amminoacidi, alcaloidi (chinino, stricnina, nicotina, caffeina) e il denatonio, la sostanza più amara conosciuta. Poiché molti alcaloidi sono tossici, l’evoluzione di questa modalità gustativa potrebbe avere un ruolo difensivo. Coerentemente questa modalità gustativa è, in tutti i mammiferi, quella con la soglia più bassa. Infatti, il chinino dà la sensazione di amaro già ad una concentrazione di 10-5 M. Le sostanze in grado di evocare una sensazione gustativa amara appartengono ad un gruppo molto eterogeneo che comprende composti sia idrosolubili sia liposolubili. Ciò sembrerebbe suggerire la presenza di più di un meccanismo di trasduzione.
Nel sistema gustativo è stata identificata una specifica proteina G, simile alla transducina24 del sistema visivo, che è stata denominata gustducina25. Topi mutanti che sono privi della subunità α della gustducina (α-gustducina) non rispondono a stimoli amari (ed anche dolci). E’ stato proposto che la α-gustducina attivi una fosfodiesterasi gustativa (PDE) la quale abbasserebbe i livelli intracellulari di nucleotidi ciclici modulando conseguentemente delle conduttanze ioniche apicali. Sono probabilmente presenti anche dei meccanismi diversi. Alcune sostanze amare (6-n- propil-tiouracile, denatonio) innalzano i livelli di IP3, determinando rilascio di calcio dai depositi intracellulari. La subunità γG13 delle proteine G colocalizza con la gustducina ed attiva una fosfolipasi (PLCβ2) specifica del sistema gustativo. Si è conseguentemente pensato alla presenza di un eterotrimero α-gustducina/β3/γ13 in cui la subunità α attiverebbe la PDE mentre il complesso βγ attiverebbe la fosfolipasi.
Inoltre la chinina ed i cationi bivalenti sono in grado di bloccare direttamente dei canali potassio situati sul polo apicale delle cellule, determinando conseguentemente una depolarizzazione cellulare. In effetti molti bloccanti dei canali potassio possono avere un gusto amaro.
3.1.2 Dolce
La struttura chimica dei composti riconosciuti come dolci è molto varia. Si tratta in genere di sostanze organiche quali polialcoli (tra cui gli zuccheri) ma anche aldeidi, chetoni e sostanze aromatiche (ad es. la saccarina). La percezione del gusto dolce sembra mediata dal legame del sapore con uno specifico recettore di membrana. La trasduzione può avvenire con due differenti meccanismi. Nei roditori l’interazione del gusto dolce, ad esempio saccarosio, con il recettore induce un aumento dalla concentrazione intracellulare di cAMP, con conseguente attivazione di una kinasi c- AMP dipendente (PKA) che fosforila, inattivandoli, dei canali potassio della porzione basolaterale della cellula. Poiché essi sono normalmente aperti al potenziale di riposo della cellula, la loro chiusura determina depolarizzazione. Sempre nei roditori, alcuni dolcificanti artificiali inducono, attraverso l’attivazione di un’altra G-protein, un incremento dell’IP3 all’interno della cellula. Questo aumento può a sua volta indurre il rilascio di calcio dai siti di
deposito intracellulari. Si è anche osservato che, in un ceppo mutante di topo nel quale è assente la α-gustducina (Vedi § 3.1.1.), vi sono dei deficit nella risposta ad alcune sostanze dolci.
L’effettivo contributo delle produzione e degradazione del cAMP e del turnover dell’IP3 nella traduzione del gusto dolce sono ancora oggetto di indagine.
3.1.3 Salato
Gli stimoli salati (ad esempio NaCl) sono tradotti almeno in parte dalla diffusione, sostenuta dal gradiente elettrochimico, di ioni Na+ attraverso canali apicali sensibili all’amiloride26. Questo influsso di sodio è di per sé depolarizzante. In effetti, l’amiloride interferisce con la capacità di riconoscere il salato nell’uomo. Un simile meccanismo può essere evocato nel caso degli ioni K+. Le differenze quantitative nella risposta evocata da diversi sali sodici possono essere dovute alla diversa abilità dell’anione di superare le tight junctions tra le cellule gustative e di interessare quindi il lato basolaterale della membrana.
3.1.4 Acido
Il gusto acido è evocato dalla dissociazione acida della sostanze sapide. Negli anfibi la percezione del gusto acido sembrerebbe dovuto al blocco di canali potassio apicali da parte degli ioni H+, con conseguente depolarizzazione. Nel criceto vi sarebbe invece un influsso di H+ attraverso i canali sensibili all’amiloride che diventano permeabili ai protoni quando la concentrazione di sodio nella saliva è bassa. Quando invece è alta, i protoni bloccano l’influsso di sodio inibendo la risposta al NaCl. Coerentemente, nell’uomo le sostanze acide riducono la risposta al salato. Infine gli ioni H+ potrebbero modulare l’apertura di canali ionici permeabili ai cationi.
3.1.5 Umami
Il glutammato e l’aspartato molto probabilmente interagiscono con una categoria di recettori gustativi a sé stanti. Si tratterebbe di recettore metabotropo per il glutammato (mGluR4) che viene espresso anche in alcune regioni del SNC. La forma specifica presente a livello delle cellule gustative è una ridotta di circa 300 amminoacidi, all’estremità amminica (extracellulare). Questa modalità gustativa viene evocata anche da 5’ribonucleotidi e dal guanilato bisodico.
